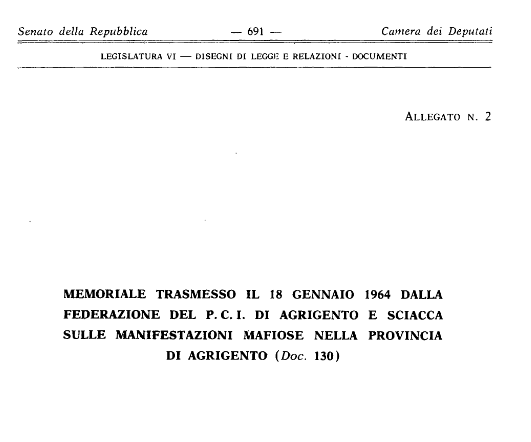Questioni di centimetri per gli avvocati del diavolo di Andrea Vianello
Questioni di centimetri per gli avvocati del diavolo
di Andrea Vianello
Fonte: aperture-rivista.it
N. 4 Anno 1998
Misure e dismisura
Sembrano muoversi in branco, l’aria un po’ guascona e distaccata di chi ne ha viste tante, e che vuoi che sia un processo in più, un processo in meno, un’altra aula bunker, un nuovo “Eccezione, signor Presidente!”. La toga stropicciata poggiata sulla 24 ore del loro turismo giudiziario, i verbali sottolineati, le strategie cavillose, e quegli occhi dalle gabbie che li seguono, li controllano, li gratificano, li rimproverano. C’è un’ombra che li segue, un mistero che li avvolge, un sospetto che gli sta alle costole: non c’è margine, non c’è scampo per chi come loro fa di mestiere l’avvocato del diavolo.
In un paese democratico il diritto costituzionale alla difesa è fondamento inderogabile: puoi chiamarti Salvatore Riina, Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Raffaele Cutolo o Antonino Imerti, puoi aver diretto la più grande e crudele organizzazione criminale d’Italia, puoi aver ordinato stragi, fatto esplodere auto-bombe, ucciso persone innocenti e rappresentanti dello Stato, sciolto nemici nell’acido, persino donne e bambini, ma la giustizia ti dà diritto ad un processo equo e davanti alla legge ci sarà sempre un avvocato a rappresentarti: è uno sporco lavoro, direbbero nei film americani, ma qualcuno dovrà pur farlo. E lo fanno loro, i legali dei boss, i difensori di Cosa Nostra, per destino, per scelta, per interesse, a volte anche per paura. Una vita sul filo del rasoio; nella guerra fra Stato e anti-Stato, loro sono forzatamente sulla linea di confine, e basta poco, pochissimo, a cadere da una parte o dall’altra.
C’è di tutto nella tribù degli avvocati del diavolo, seri professionisti, personaggi ambigui, azzeccagarbugli e prìncipi del foro, onesti e collusi, ma un denominatore comune li unisce indissolubilmente: il bordo del precipizio su cui sono costretti a camminare radente. Davvero questione di centimetri, davvero una questione di misura o dismisura.
Come si diventa legali di un boss? “Gli avvocati si scelgono a seconda del presidente della Corte”, ha raccontato una volta Gaspare Mutolo, ex uomo d’onore della famiglia di Partanna Mondello, ora pentito di peso, “se sappiamo che un presidente è democristiano, scegliamo un avvocato democristiano, se invece un presidente è comunista, scegliamo l’avvocato comunista”. Lottizzazione consapevole o strategia processuale della Cupola all’insaputa del legale? Importa poco, quando poi si è lì a combattere contro un muro d’accusa e una sentenza praticamente certa di colpevolezza.
Una volta era tutto diverso, ai processi per mafia non si arrivava quasi mai e se ci si arrivava i margini di manovra erano ampi, per gli avvocati ed i loro assistiti c’era bell’ e pronta l’assoluzione per insufficienza di prove, male che andasse ci pensava magari la Cassazione a rimettere a posto ogni cosa. Ora i tempi sono cambiati, le gabbie sono piene, le inchieste non si fermano, gli ergastoli piovono come pietre ed è persino caduto il tabù più rassicurante: quello che Cosa Nostra non li fa fuori, mai, i propri legali. Quante storie, quante facce, quanti aspetti diversi tra gli avvocati del diavolo.
Ce ne sono molti che quei centimetri fatali li hanno attraversati dalla parte sbagliata, o magari non hanno dovuto neanche farlo, poiché ci si erano trovati fin dall’inizio nel territorio nemico: uomini d’onore fin dalla nascita, destinati alla professione forense perché un avvocato in Famiglia fa comodo eccome; figli di notabili, notabili anch’essi e padri di futuri notabili, organici, inseriti, rispettati, indispensabili, trattati dal destino con i guanti gialli grazie al ruolo preziosissimo di mediatori tra l’abisso dell’illegalità e gli studi professionali con la scrivania in mogano. Per molti di loro è stato il fiume del pentitismo, l’ondata dilagante dei collaboratori di giustizia a rompere gli argini della propria sicurezza; e la Camera Penale palermitana ha visto cadere molte toghe di prestigio sotto rinvii a giudizio e mandati di cattura per favoreggiamento: Gaetano Zarcone, per lungo tempo latitante, Salvatore Chiaracane, condannato fino in terzo grado, persino Francesco Musotto, uno dei Leader di Forza Italia in Sicilia, ex presidente della Provincia che è finito sotto processo dopo un arresto per mafia gonfio di polemiche: Pierfrancesco Bonocore, che nel foro di Palermo ha fatto storia, avvertiva i suoi giovani collaboratori di diffidare delle tre C: “Canaglie, clienti e colleghi”.
I collusi, quarta C, i collusi riconosciuti, colti in flagrante troppi centimetri in là della linea di confine, restano comunque in minoranza. Attorno c’è il grande mondo degli ambigui, su cui gravano sospetti, illazioni, deduzioni, indizi, ma che per ora resistono in equilibrio: l’esempio più eclatante, e forse più precario, degli ultimi tempi si chiama Vito Ganci. Originario del paese più caldo dei nuovi scenari di mafia, San Giuseppe Jato, dei signori di quel paese abbandonato nel cuore della Sicilia, i Brusca, Vito Ganci è stato per venti anni il difensore privilegiato. Studio a Roma e a Palermo, villa sull’Appia vicina a quella dell’ex ministro della giustizia Martelli, eloquio sanguigno, toni sbrigativi, aria sempre indaffarata: Vito Ganci difende per anni l’indifendibile, rappresenta Giovanni Brusca anche quando questi è il latitante più ricercato in Italia, il killer feroce che ha sciolto nell’acido il figlio undicenne del pentito Santino Di Matteo. Ma poi Brusca finisce per essere catturato e aspetta solo pochi mesi a far nascere il balletto ambiguo della sua presunta collaborazione con lo Stato, tuttora irrisolta, tanto che l’ex boss di San Giuseppe Jato è ancora oggi un semplice dichiarante.
Ma è l’avvocato Ganci in quel balletto a compiere le giravolte più pericolose, reagendo come un tarantolato alla notizia del pentimento del suo assistito, con interviste gridate ai quattro venti dove rivela che nei suoi colloqui con Brusca questi gli raccontò di aver avuto incontri proibiti con altissimi personaggi delle istituzioni. Tutto falso, più tardi ammetterà lo stesso Brusca, confessando il suo progetto destabilizzante col quale voleva “inguaiare” nientemeno che il presidente della Camera Luciano Violante, approfittando di un viaggio Roma-Palermo compiuto casualmente sullo stesso aereo, ma il ruolo di Ganci in una delle vicende più astruse e velenose degli ultimi anni resta sospeso. Era complice o vittima anch’egli delle bugie del capomafia? La Procura di Palermo lo torchierà in numerosi interrogatori fiume, lui si auto-sospende dal foro, ma un’ombra nera e pesante sembra calata su di lui, stavolta il super difensore di Cosa Nostra si è spinto troppo in là e non può tornare indietro.
Successe qualcosa di analogo in modi diversi e in tempi che appaiono ormai lontanissimi anche a quello che più di ogni altro la categoria degli avvocati della Cupola si trova a rappresentare diremmo per rigore gerarchico: il legale del boss dei boss Totò Riina, Cristoforo “Nino” Fileccia. Lui, che difende il numero uno della Piovra praticamente da sempre, fin da quando “zu Totò” era ancora un aggressivo picciotto di Corleone che iniziava la sua scalata ai vertici dell’organizzazione, è uomo cauto, dal sorriso furbissimo e dai lampi d’astuzia. Eppure prese tutti di sorpresa quando nel luglio del 1992, proprio in mezzo alle due terribili stragi palermitane che eliminarono i nemici storici di Cosa Nostra, Falcone e Borsellino, si presentò davanti alle telecamere della RAI, sui gradini del palazzo di giustizia, per dichiarare che l’allora latitante Riina, in fuga da più di vent’anni, lui lo incontrava frequentemente, e mica all’estero, ma proprio lì, in Sicilia.
“Il diavolo non è cattivo come sembra”, volle rassicurare gli italiani e poi aggiunse rivolto proprio a Riina che credeva nella sua innocenza e che avrebbe continuato a combattere per dimostrarla fino alle estreme conseguenze. Si scatenarono mille polemiche, il capo della Criminalpol Luigi Rossi definì le dichiarazioni di Fileccia “un’autentica provocazione mafiosa”, di certo l’avvocato veicolò un messaggio, probabilmente diretto verso l’esercito di Cosa Nostra. Ma c’era nulla di illegale in ciò che aveva fatto e detto? Rientra nelle prerogative del difensore incontrare il proprio assistito anche se questi è latitante, e in un’intervista in TV non è reato penale. Ma fu la prima e ultima volta che Nino Fileccia decise di uscire così allo scoperto, da allora è praticamente impossibile carpirgli alcuna dichiarazione al microfono: di tutti i legali dei boss è quello col compito più difficile e delicato, è un acrobata sul vuoto che conosce a memoria l’asse di equilibrio, è un maestro nell’arte della riservatezza, e se quel giorno si espose troppo al sole era perché doveva farlo, farlo una volta e basta.
Per chi va fuori misura, in un modo o nell’altro, non c’è più ormai solo lo spettro delle manette. Muoversi male nella parte sbagliata, restare troppo rigidi nella parte giusta, può costare la vita. Perché se una volta l’avvocato era sacro e nessun mafioso avrebbe mai pensato di organizzare un omicidio contro chi indossa la toga fra i banchi della difesa, oggi, che nessun codice di presunto onore protegge più neanche donne, bambini e parenti, la lista dei difensori licenziati con la morte si va ingrossando. Si può morire di camorra come Anjo Arcella, legale chiacchieratissimo, anzi già condannato per favoreggiamento, che venne crivellato di colpi in un vicolo di Napoli nel 1997, due ore dopo la sua ultima arringa in difesa del clan giuliano, durante la quale aveva tuonato profeticamente “Avvocati, il nostro mestiere è sempre più a rischio, siamo esposti alle vendette dei clienti che vogliono il risultato ad ogni costo.”: (** ma la vendetta che colpì lui fu più probabilmente quella della cosca rivale).
Oppure fare una fine più nobile e più tragica come l’avvocato Serafino Famà da Catania, definito poi dai colleghi durante la cerimonia funebre “uno giusto, un onesto, il più puro di noi”. Così puro che i boss catanesi ritenevano usasse metodi troppo corretti e poco vantaggiosi per tirarli fuori dai loro giganteschi guai giudiziari, e gli mandarono due sicari sotto lo studio in una sera di novembre. “È lei l’avvocato Famà?”, gli chiesero nel buio e gli spararono in faccia. Un delitto che serviva da avvertimento e da lezione a tutta la categoria forense: persino Nitto Santapaola, il cacciatore, si dissociò da quell’omicidio.
Ma il dado è tratto, ora tutti i legali dei boss lo sanno che con il loro lavoro possono anche giocarsi la vita. E così nei processi di mafia che ormai non si contano più, loro sono lì, sorridenti ma sempre sospettosi, pronti ad urlare in aula che in Italia lo strapotere dei pubblici ministeri rende impossibile il loro compito, che i diritti della difesa sono schiacciati, distrutti, annientati; rimproverano i giornalisti perché a loro il microfono non lo porgono quasi mai, e con i boss nelle gabbie che li guardano un po’ scettici un po’ fiduciosi, danno il via allo show, che più sarà lungo e più sarà apprezzato. Contestazioni, eccezioni, opposizioni, interventi pirotecnici, tesi cervellotiche, codice penale sempre alla mano, controinterrogatori interminabili, e ancora contestazioni, eccezioni, opposizioni, finché il Presidente della Corte, sfinito, controlla l’orologio e aggiorna l’udienza.
Ecco, hanno già ottenuto qualcosa, prolungando poco a poco i tempi del processo, rinviando anche solo di un giorno il verdetto e la sicura condanna, e se ne vanno senza guardare le gabbie, ma convinti di aver fatto il proprio dovere affinché nessuno possa ritenersi insoddisfatto.
Nino Fileccia, inesauribile narratore di aneddoti, ha una storia che predilige: si riferisce ad un vecchio processo, con la deposizione del pentito storico Totuccio Contorno. Il presidente di quel dibattimento era un uomo severo e intollerante, che odiava il fumo e proibiva a chiunque di accendere una sigaretta in aula, pena l’espulsione immediata. Fileccia, fumatore incallito, soffriva in silenzio, perché non poteva perdere nemmeno una parola di quella deposizione, ma moriva dalla voglia di tirare qualche boccata. Ad un certo punto non ce la fece più: si alzò dai banchi, aprì la porta d’ingresso dell’aula e rimase così, in mezzo, soffiando il fumo di fuori in modo che nessuno potesse accorgersene. Ma il naso del presidente avvertì l’inganno. “Chi sta fumando? È lei, Contorno?”, esplose il giudice. “No, signor Presidente, non sono io”, si difese il pentito, “è l’avvocato Fileccia”, rivelò indicandolo. Il legale di Riina si fece allora rosso in volto, ma con un gesto rapidissimo spostò la sigaretta nella mano che si trovava al di là della porta aperta e disse “Sì, signor Presidente, sto fumando, ma come vede la sigaretta è fuori dall’aula.” Anche in quel caso per pochi centimetri salvò la faccia e poté continuare a seguire la deposizione. Ma la sigaretta fu costretto a spegnerla comunque.
**
Fonte: ilmattino.it
Articolo del 21 novembre 2015
Napoli. Fece uccidere l’avvocato Arcella, 15 anni a Raffaele Giuliano ex boss di Forcella
NAPOLI – Quindici anni di reclusione è la condanna inflitta dalla Corte di Assise di Napoli a Raffaele Giuliano, detto ‘o Zu¡, esponente della nota famiglia camorristica di Forcella e fratello del boss Luigino. Raffaele Giuliano è stato riconosciuto responsabile di essere il mandante dell’omicidio dell’avvocato Anyo Arcella, avvenuto a Napoli il 19 dicembre 1996.
Il pubblico ministero Henry John Woodcock al termine della requisitoria aveva chiesto 20 anni di carcere. Arcella sarebbe stato ucciso per impedire che il boss Luigi Giuliano, fratello maggiore dell’imputato, collaborasse con la giustizia. Nel corso degli anni anche Raffaele Giuliano si è pentito. Per il delitto sono stati già condannati i due esecutori materiali, Fabio Riso e Gennaro Barnoffi.
L’avvocato Arcella, è emerso dalle indagini, fu ucciso perché nel rione Forcella si temeva che potesse convincere Luigi Giuliano a pentirsi, circostanza che si verificò comunque alcuni anni dopo. Preoccupati per le conseguenze che questa scelta avrebbe potuto avere per loro, alcuni affiliati chiesero a Raffaele Giuliano la testa del legale, che fu assassinato la sera del 18 dicembre 1996, poco dopo avere lasciato l’abitazione del boss Luigi.